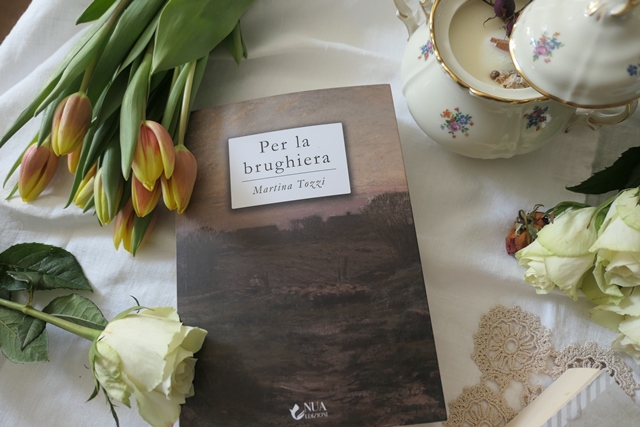Chi scrive inevitabilmente inserisce pezzi di sé nelle proprie opere, attinge dal pozzo delle proprie esperienze, dei propri ricordi, del proprio sentire per tratteggiare personaggi, descrivere emozioni, raccontare storie. E questo è vero più che mai per le sorelle Brontë.
Leggere Jane Eyre, Cime tempestose o La signora di Wildfell Hall senza conoscere la vita di Charlotte, Emily o Anne impedisce di cogliere quanta della loro esperienza di vita si sia riversata nelle pagine che hanno scritto.
Per la brughiera di Martina Tozzi ci racconta, con la profondità e delicatezza che la contraddistinguono la biografia di queste tre donne assolutamente rivoluzionarie per la loro epoca e per tutta la storia della letteratura, permettendo di cogliere richiami ed ispirazioni reali che si sono riversate nelle loro opere letterarie.
E lo fa partendo dall’inizio, da quella canonica di Haworth, spersa in un angolo di Yorkshire – nella parte centro settentrionale dell’Inghilterra, caratterizzata da grandi spazi aperti e aspre brughiere spazzate dal vento -, dove esercita la sua funzione di pastore il reverendo Patrick Bronte, di origini irlandesi, che assiste impotente alla morte della moglie che lo lascia con sei figli di età compresa tra gli otto e l’anno di età.
Per dare un’educazione alle figlie che permetta loro di fare le istitutrici o le insegnanti, consapevole che, qualora non trovassero marito, rischierebbero l’indigenza, manda le due più grandi Maria ed Elizabeth nella scuola di Cowan Bridge nel Lancashire, un istituto per figlie di ecclesiastici, dove, poco dopo, accederanno anche Charlotte e Emily. La scuola è un luogo tetro, con vitto insufficiente e condizioni igieniche inadeguate: le bambine dormono in due in un letto, senza riscaldamento, pasti scarsi e una disciplina rigida. Mary e Elizabeth si ammalano entrambe di tubercolosi e nonostante il ritorno a casa muoiono a distanza di un mese l’una dall’altra. Il padre decide allora di ritirare da scuola le due più piccole. Da quel momento i quattro fratelli ricevono un’educazione composita ed avanzata per il periodo storico. Il padre li lascia liberi di leggere e discutere, tutti e quattro scrivono e dalla loro fantasia scaturiscono delle saghe fantasiose che alimentano a non finire i loro giochi. E colpisce l’immagine delle sorelle che camminano parlando delle loro opere intorno al tavolo o scrivono ognuna immersa nel proprio mondo interiore sempre intorno a quel tavolo. Tutte dotate di un talento, di un’immaginazione e di una passione senza limiti.
Mentre placidamente Emily e Anne continuavano a giocare e trascrivere per il loro unico piacere personale, Charlotte e Branwell venivano percorsi dallo stesso, identico pensiero: anche loro possedevano quel demone. Anche loro erano dei geni, nel loro sangue correva la scrittura, come una maledizione e una benedizione insieme: dovevano scrivere, comporre, dovevano mettersi alla sedia, intingere la penna d’oca nell’inchiostro e poi passarla sulla carta, e creare parole, frasi, mondi e sentimenti nuovi. E, se come Byron sentivano quella fame, quel desiderio implacabile di scrivere, allora come lui avrebbero conquistato la fama, per sempre.
E nel delineare la vita di questi quattro giovani, le loro esperienze lavorative e non, le partenze e i ritorni a casa l’autrice delinea la loro personalità.

Emily che basta a se stessa, uno spirito indomito, indipendente, fiero. Ha il fuoco dentro. Vive in totale interconnessione con la natura, ama tutte le creature viventi animali e piante comprese. I fenomeni meteorologici estremi, il vento, le tempeste la affascinano, come il richiamo della brughiera. Lei non ha nessun interesse ad abbandonare la canonica ad andare a conoscere altro, ama la sua casa, il suo piccolo intenso mondo interiore è concentrato a Haworth. La sua fantasia non ha limiti né confini, scrive solo per se’. Le parole e le storie le scaturiscono dalla passione interiore, per questo non intende piegarsi al giudizio degli altri, che vede come un limite, un freno, che lei non vuole, non accetta. Pubblicherà dietro pseudonimo Cime tempestose solo per le pressioni di Charlotte e Anne. Un’opera originalissima, che non nasce, a differenza delle sorelle, da esperienze personali, ma dalla sua ispirazione, libera e selvaggia, senza freni né inibizioni.
Anne è la più mite. Quella che emerge di meno, che osserva di più. Pronta a fare il suo dovere quando è necessario, a lasciare la casa tanto amata per andare a fare l’istitutrice, a prendersi le sgridate dei genitori che non la giudicano adatta, ad affezionarsi ai ragazzini. Eppure è sempre lei a dare origine ad un personaggio come Helen, una protagonista moderna, anticonvenzionale, decisa, determinata, forte, che non si lascia piegare dalle situazioni che le capitano ma esce a testa alta da tutte le traversie e sofferenze ne La signora di Wildfell Hall.
Infine, Charlotte tra le tre sorelle la più sfaccettata, la più complessa la più inquieta.
Vive spezzata a metà, con un fortissimo senso del dovere, perché non vuole deludere il padre, sa che i mezzi della famiglia sono limitati e che deve lavorare per potersi mantenere, ma anche determinata a vivere del proprio lavoro, a diventare scrittrice, non per diletto, non per passare il tempo, ma come occupazione che le dia un reddito e le permetta di mantenersi, di essere autonoma. Pur amando la sua casa, le sue sorelle, il padre sente fortissimo il desiderio di uscire dalla canonica di Haworth, di vedere il mondo, di confrontarsi con altre esperienze.
I ruoli di istitutrice, d’insegnante non le calzano, non sono ciò che vuole fare. Oltretutto questi ruoli, quasi le uniche figure professionali consentite all’epoca per le donne istruite, erano poco riconosciuti: un’istitutrice non era una domestica ma non era nemmeno una di famiglia, viveva in una sorta di limbo, guardata con sospetto sia da chi stava più in basso nella scale sociale sia da chi stava sopra. Un’ombra che funzionava solo in relazione ai compiti che doveva svolgere. Una figura insignificante, isolata dagli altri, un ruolo marginale che ricoprivano le donne senza dote, quindi pressoché escluse dalla possibilità di sposarsi, che dovevano guadagnarsi da vivere da sole.
Forse perché era donna doveva essere un’immaginetta spenta e noiosa, senza sogni, senza ambizione alcuna se non quella di compiacere un marito – e lei, ormai da tempo, si era convinta che mai ne avrebbe avuto uno – paga solo di compiere il proprio dovere? Non esistevano donne di tale foggia, le donne, come gli uomini, erano creature fatte di carne, cuore palpitanti e sogni, e come gli uomini avevano cervelli pensanti e immaginazione in cui rifugiarsi, e desideri e aspirazioni. Erano stati gli uomini a creare quel modello serio e tranquillo di una donna mite e ansiosa di obbedire.
A differenza di Emily vuole un pubblico che l’apprezzi, vuole un riconoscimento sociale.
Si sente limitata dal fatto di essere donna, perché un libro non ha sesso, ma è la società a imporre dei limiti ad una donna.
«In ambito letterario, vorrei semplicemente essere considerata senza genere. I libri non hanno sesso, mi pare, e allora perché deve essere così importante quello del loro autore?»
E’ quella che conosciamo di più, grazie alle lettere, agli incontri con l’editore, inoltre ha scritto più libri, si è esposta maggiormente rispetto alle sorelle ed è inevitabile che a lei sia dedicato più spazio.
Martina Tozzi non dimentica, però, nemmeno Branwell, l’unico fratello, che seppur non pubblicò nulla e fu, in più occasioni, uno spina nel fianco per la famiglia, fece parte di quell’incredibile cerchio magico che vide svilupparsi un talento senza pari in un oscuro angolo di mondo. Branwell, un ragazzo dotato di talento sia nella pittura che nella scrittura, incline però a seguire cattive compagnie, contrarre debiti, diventare preda dell’alcool e del laudano, disperdendo così i suoi doni.
Per la brughiera è un romanzo intenso, pieno di emozioni e di pathos, impossibile rimanere indifferenti di fronte alle tante difficoltà che dovette superare la famiglia Brontë e a non commuoversi davanti ai lutti che si susseguirono in modo tragico. Le ultime pagine straziano il cuore al pensiero di Charlotte ormai rimasta sola, che assapora per la prima volta una sorta di felicità, prima che la mannaia del destino si abbatta ancora una volta su di lei…
Una biografia romanzata, arricchita in epigrafe ad ogni capitolo da versi delle sorelle o del fratello, che permette, oltretutto, come dicevo all’inizio di cogliere nei romanzi delle sorelle Brontë aspetti ed elementi confluiti dalle esperienze personali, rendendo più consapevoli della ricchezza del loro mondo interiore.
Per la brughiera di Martina Tozzi – Nua edizioni (2023) – pag. 456