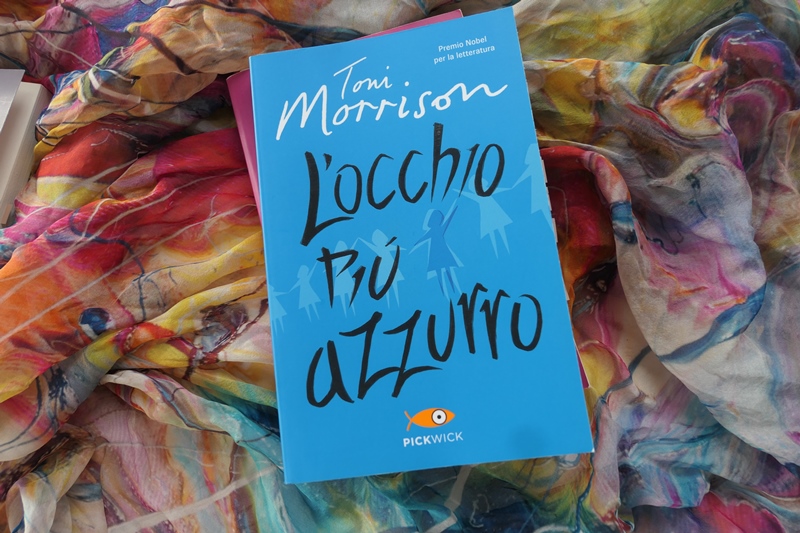Quanto può essere drammatica l’infanzia di una bambina che si vede brutta e che sogna di essere graziosa come la Shirley Temple dei film che ammira sul grande schermo?
Perché Pecola, la piccola protagonista de L’Occhio più azzurro, il primo romanzo di Toni Morrison, sogna di avere gli occhi azzurri della piccola attrice che tutta l’America ama, affinché finalmente gli altri la trovino bella, e beve tre litri di latte solo per poter tenere tra le mani la tazza dove è impressa proprio l’immagine di Shirley Temple.
Ecco tutto.
Una bambina nera che desidera gli occhi azzurri di una bambina bianca, e tutto l’orrore nel profondo di questo desiderio non è niente rispetto al male della sua realizzazione.
Il romanzo di Toni Morrison è un vero pugno nello stomaco, affilato e crudele, per certi versi molto più di Amatissima. Nel romanzo forse più conosciuto dell’autrice americana la sofferenza del popolo nero è manifesto. È sulla loro pelle, nella loro carne che l’uomo bianco, credendosi superiore, ha impresso il marchio, vendendoli, comprandoli e trattandoli come delle bestie: proprietà del padrone, senza diritti e senza sogni, se non in una fuga spesso impossibile. E tra tutte le eredità di discriminazione, di spregio, di inferiorità, di cancellazione delle origini che gli ha lasciato, forse la peggiore è il disprezzo verso se stessi, verso il colore della pelle.
E proprio sul disprezzo verso il colore della propria pelle si concentra la narrazione di questo romanzo, ambientato all’inizio degli anni quaranta, in una società che vede i neri “liberi” – almeno sulla carta -, ma che non ha cambiato lo sguardo dei bianchi nel considerare i neri meno di niente e soprattutto non ha dato loro né prospettive né possibilità, solo sogni spezzati, debiti e segregazionismo.
Lei lo guarda dal basso in alto e dove dovrebbe esserci curiosità vede il vuoto. E altro ancora: l’assenza totale di riconoscimento umano – uno sguardo lontano, di ghiaccio. Lei non sa che cosa sia a tenere sospeso lo sguardo di lui. Forse perché è adulto, o è un uomo, e lei è una bambina. Eppure ha visto interesse, disgusto, persino rabbia degli occhi degli uomini. Tuttavia questo sguardo vuoto non è nuovo per lei. Ha un bordo tagliente: da qualche parte nella palpebra inferiore c’è repulsione. L’ha vista in agguato negli occhi di tutti i bianchi. Ecco. La repulsione dev’essere per lei, perché è nera. Tutto in lei è mutamento e attesa, ma il suo colore nero è statico e spaventoso. Ed è il nero che spiega, che crea, quel vuoto delimitato della repulsione negli occhi dei bianchi.
La linea del colore è diventata un baratro, perché le persone con un colore più chiaro sono più accettate e hanno meno difficoltà ad integrarsi, mentre chi ha la pelle più scura si trova in fondo alla catena, considerato meno che niente.
Bambini bianchi: a sua madre non piaceva che giocasse con i negri. Gli aveva spiegato la differenza tra la gente di colore e i negri. La gente di colore era pulita e silenziosa, i negri erano sporchi e rumorosi.
Morrison inizia L’occhio più azzurro con un brano tratto da un sussidiario scolastico, piuttosto diffuso nelle scuole elementari degli Stati Uniti in quegli anni, l’affresco della tipica famiglia bianca: padre, madre, due figli un cane, un gatto e una casa bianca e verde dalla porta rossa. Tutto carino, tutto lindo, tutto perfetto. Esattamente tutto il contrario della storia che si dipanerà da lì a poche pagine. E così la narrazione, scandita dalle quattro stagioni, alterna il racconto di Claudia, una delle due sorelle la cui famiglia ospita proprio Pecola, dopo che la sua casa ha preso fuoco, e la famiglia si è trovata per strada, con le vicende dei genitori di Pecola – i cui capitoli sono intitolati con pezzi del brano del sussidiario. Un padre violento e ubriacone, abbandonato appena nato, traumatizzato da un’esperienza avuta in gioventù. Una madre con un piede piatto e storto, a causa di un chiodo arrugginito, che si rifugia in un mondo di fantasia. Felice solo quando sta a servizio dalla sua padrona bianca tra tappeti soffici, muri puliti, stoviglie lavate e asciugamani profumati. Una coppia che si è scelta e si è amata prima che tutto andasse a rotoli.
Morrison alterna il racconto in terza persona a quello in prima di Claudia, il cui sguardo è lucido ma anche pieno di compassione verso il destino crudele di quella che sente come un’amica più sfortunata di lei. Nonostante anche Claudia sia povera, la sua famiglia è meno disastrata, più unita, lei ha una sorella con cui condividere le esperienze più brutte, una spalla su cui appoggiarsi e sostare. E poi lei odia Shirley Temple, la odia perché trova ingiusto che quella mocciosetta bianca, debba, tra mossette e sorrisi, ballare con Bojangles, che lei sente amico, “zietto” e “papà”. Un odio nato, quando un Natale ha ricevuto quello che doveva essere il regalo ideale per ogni bambina: una bambola “dagli occhi tondi e inespressivi, la faccia a frittella e i capelli come lombrichi arancioni”. E la odia a tal punto da smembrarla, perché l’unico sentimento che le genera quella bambola “con gli occhi azzurri, i capelli biondi e la pelle rosa” è vedere come è fatta dentro per cercare “di scoprire il segreto che la rendeva così bella e preziosa agli occhi di tutti, tranne che ai suoi”.
In L’occhio più azzurro altre vicende, torbide e scioccanti, e altri personaggi si intrecciano con la storia principale, per raccontare un universo di privazioni, sofferenze, perdita del senso d’identità, e concentrarsi sul destino di una bambina senza speranza perché nessuno si prende cura di lei, nessuno riesce a vedere al di là del colore della sua pelle.
Tutti noi – tutti quelli che la conoscevano – ci sentimmo sani dopo esserci purificati su di lei. Eravamo bellissimi quando stavamo accanto alla sua bruttezza. La sua semplicità ci decorava, la sua colpa ci santificava, il suo dolore ci faceva scoppiare di salute, la sua goffaggine ci faceva pensare di essere brillanti. I suoni inarticolati ci facevano credere di essere eloquenti. La sua povertà ci rendeva generosi.
Toni Morrison, già da questa sua prima opera, reinventa la scrittura, la spezza, sperimenta, dando “forma al silenzio” e ricercando “una scrittura indiscutibilmente nera”, come il jazz, unica forma artistica afroamericana, che “sottolinea l’integrità spirituale dell’individuo e la sua comunione con gli altri”.
L’occhio più azzurro è un romanzo forte, a cui viene da ripensare a distanza di tempo. Emotivamente coinvolgente e per certi versi devastante, ma necessario come ogni libro che ci illustra come siamo ancora lontani da un mondo ideale, dove l’infanzia sia un giardino pieno di prospettive e le vite abbiano tutte lo stesso valore.
L’occhio più azzurro di Toni Morrison [The Bluest Eye 1970] – Frassinelli Pickwick (2018) – traduzione di Luisa Balacco – pag. 230