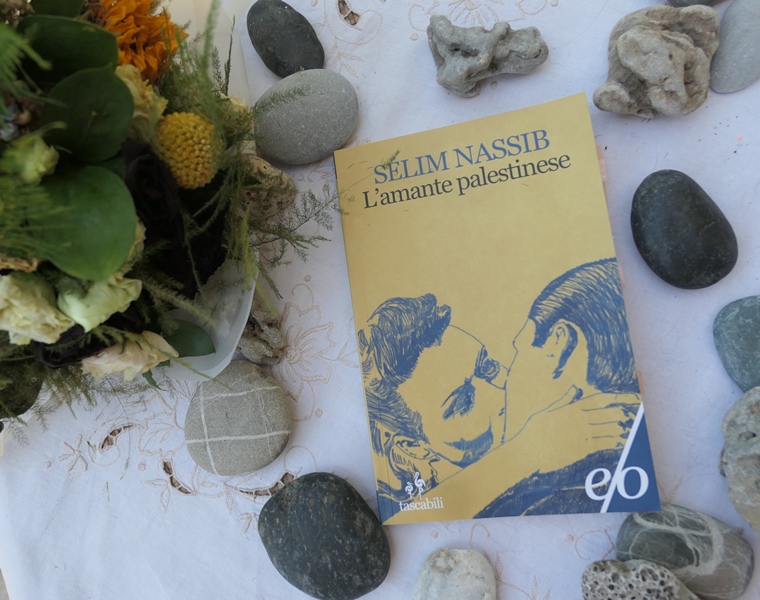Ogni libro che leggiamo rappresenta un ulteriore tassello che si incastra come in un enorme puzzle e va a comporre nel nostro cervello un immagine più grande, regalandoci uno sguardo più profondo e compiuto su fenomeni o periodi storici. E’ quello che mi è capitato leggendo L’amante palestinese di Sélim Nassib, che nel raccontare la relazione di Golda Myerson (futura Golda Meir, Primo Ministro di Israele negli anni ‘60), con Albert Pharaon, banchiere palestinese, ci offre l’occasione di approfondire un pezzo di storia e capire, ancora una volta, come tutto non sia iniziato il 7 ottobre 2023.
“Essere ebrei non li distingue più” pensa Morris, “perché tutti sono ebrei. Per presentarsi sono costretti a definirsi yemeniti, russi, lituani, tedeschi, siriani… La Palestina ha permesso loro di realizzare un desiderio tanto profondo quanto inconfessato: non essere più ebrei!”.
Al di là della storia sentimentale clandestina tra due persone entrambe sposate, divise da un’infinità di differenze, quello che spicca in L’amante palestinese è la ricostruzione del periodo storico. Il libro abbraccia il periodo ricompreso tra il 1923 e il 1948 in Palestina, territorio individuato geograficamente nella regione tra Fenicia e Egitto e caratterizzato da insediamenti umani antichissimi, provincia prima dell’Impero Romano, quindi dell’Impero Bizantino e successivamente di quello ottomano, ed identificato dagli ebrei con la zona chiamata nella Bibbia ebraica “Terra di Canaan” e “Terra di Israele”.
Prima della fine della prima guerra mondiale, quando era ormai certa la caduta dell’Impero ottomano, contraddistinto per quasi cinque secoli da una convivenza per lo più pacifica tra le varie religioni e tra le varie etnie, viene firmata la Dichiarazione Balfour. Una lettera, datata 2 novembre 1917, inviata da Arthur Balfour, l’allora ministro degli esteri dell’Impero Britannico – la cui sfera d’influenza e controllo globale all’epoca è paragonabile a quella degli Stati Uniti oggi -, a Lord Rothschild, quale principale rappresentante della comunità ebraica britannica e referente del movimento sionista, con la quale il governo inglese affermava di guardare con favore alla creazione di una “dimora nazionale per il popolo ebraico in Palestina.
Una “promessa” che si scontrava con l’impegno che, sempre i britannici, avevano preso nel 1915 (tramite accordi tra Sir Henry McMahon, in nome del governatore britannico, e lo sharif della Mecca, Husayn ibn ‘Ali) di appoggiare la nascita di un paese indipendente o una sorta di provincia di una confederazione araba, per l’aiuto prestato nella lotta contro l’Impero ottomano.
D’altra parte, gli Stati arabi e la maggioranza della popolazione araba palestinese non potevano appoggiare l’idea della formazione di uno Stato non islamico in Palestina.
Nel 1920, con la firma del trattato di Sevres, la Palestina finisce sotto mandato britannico e inizia il primo insediamento sionista, con una progressiva e sempre più massiccia immigrazione ebraica nella zona.
Seppur la dichiarazione Balfour non parlasse della creazione di un vero Stato indipendente, e contenesse un esplicito riferimento ai “diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della Palestina” che non dovevano essere danneggiati, l’intenzionale ambiguità del testo, alimentò l’immigrazione soprattutto dall’Europa orientale, dove persecuzioni antisemite e pogrom erano più che mai ricorrenti. L’idea di poter avere finalmente uno stato sicuro, oltretutto nei luoghi della “terra promessa” di biblica memoria, dove persecuzioni e esodi non esistevano più, spinsero tantissime famiglie a emigrare in Palestina. Lì iniziarono ad acquistare terreni, e a creare i primi insediamenti, tra cui la fondazione dei primi kibbutz, comunità agricole basate sulla proprietà collettiva e fondate su regole rigidamente egualitarie, in cui ogni singolo lavora e si opera a favore della comunità.
Ed è in un kibbutz che il lettore incontra per la prima volta Golda Myerson, ucraina, profondamente traumatizzata dai diversi pogrom a cui ha dovuto assistere durante la sua giovinezza, emigrata negli Stati Uniti, ma decisa a trasferirsi in Palestina per iniziare una nuova vita e decisa a costruire uno Stato di ebrei per gli ebrei.
Per lei il passato non era morto, non si sentiva ancora pronta a gettarlo dalla finestra come i vecchi immigrati consigliano di fare ai nuovi. Il traguardo non era l’America. Fin quando non saranno padroni del proprio destino e della propria sicurezza, diceva, gli ebrei non possono considerarsi arrivati. Questa convinzione incrollabile l’aveva condotta in Palestina.
Ed è questo il fulcro su cui, a distanza di un secolo, occorre concentrare l’attenzione: la Palestina era una terra dove vivevano pacificamente arabi e ebrei, cristiani e beduini, non un deserto inabitato. Ma gli ebrei, giunti dall’Europa, traumatizzati da millenni di persecuzioni, volevano uno stato proprio, uno stato di soli ebrei, non una nazione da condividere con chi da millenni sulla quella terra già ci viveva. E la miopia occidentale ha creato le basi per quello che è accaduto dopo, nonché quello a cui stiamo assistendo oggi.
«Con gli ebrei noi siamo sempre andati d’accordo. Sono figli di arabi come noi».
«Quelli che vengono dall’Europa sono un’altra cosa».
«Cosa vi è preso? Perché diavolo la Gran Bretagna aveva bisogno di promettere una “patria nazionale” agli ebrei in un paese arabo? Non vedo come questa politica potesse servire i vostri interessi».
«È il “divide et impera”».
«Dividere tra chi e chi? Gli ebrei non rappresentano nemmeno il dieci per cento degli abitanti della Palestina. I britannici si inimicano una nazione estremamente popolosa in favore di un’ipotetica nazione futura.»
Il romanzo esplora la nascita e l’affermazione sempre più convinta del Sionismo, basato sul fatto che le comunità ebraiche necessitassero di un proprio Stato, dove potessero prosperare in sicurezza e lontani dell’antisemitismo, e al contempo descrive l’esplosione della tensione tra le due popolazioni che sfocia nella violenza. Per questo nel 1930 i britannici pubblicano il primo Libro Bianco, in cui dichiarano che è necessario bloccare l’immigrazione di nuovi ebrei per evitare un innalzamento della tensione nella regione. Il crescente antisemitismo e le persecuzioni naziste portano però ad un nuovo cambio di rotta e nel 1936 i britannici propongono un nuovo Libro Bianco, offrendo agli ebrei un terzo dei territori Palestinesi, mentre agli arabi rimarrà il resto, condizione però che quest’ultimi non accetteranno. Fino alla violenza incontrollata e senza limiti della Nakba: la spoliazione, distruzione e cacciata dei palestinesi dalle loro terre e dalle loro case.
«Oggi non siamo più a casa degli altri, e non chiediamo a nessuno il permesso di vivere. Al contrario, affermiamo il nostro diritto di tornare nel paese dei nostri antenati, di stabilirci, di coltivarne la terra e di svilupparne le risorse, senza impedimenti. Noi non siamo stranieri in questo paese, ma i discendenti di coloro che in passato ne erano i signori! Torniamo per insediarci, ed è come se fossimo nati qui!»
In L’amante palestinese quello che colpisce di più è la figura di Golda Meyer, assolutamente convinta del “diritto al ritorno” degli ebrei nella loro patria ancestrale, determinata a dare una nazione al proprio popolo, a non dover più affrontare pogrom o persecuzioni, indifferente al destino del popolo palestinese, cieca all’altrui sofferenza.
“Tu non conosci la società palestinese” mormora Albert. “È povera, per tre quarti analfabeta. Non capisce nulla di quanto le sta succedendo. Le terre vengono comprate e i contadini, trasformati in fantasmi, infestano le strade di Haifa e di altre regioni. Non sanno nemmeno più con chi lamentarsi né con chi prendersela. Per dieci anni i palestinesi si sono fidati dei propri dirigenti, senza rendersi conto che questi ultimi erano impotenti o complici. E quando l’hanno capito, alcuni sono impazziti e hanno risposto selvaggiamente alla violenza inafferrabile che subivano. È orribile. Ma voi siete in questa terra, tra questa gente. Non avete scelta. Siete obbligati a vivere con noi”.
Golda non ha sentito nulla, è cieca. Ma alle ultime parole di Albert trasale come per effetto di una scarica elettrica. Ha voglia di ucciderlo. Albert vede che ha voglia di ucciderlo. Lei grida:
“Noi? Chi sono questi noi? Noi siamo venuti qui per non dipendere più da nessuno, capisci? Non ci sono altri all’infuori di noi!”
Per questo per Golda Meir, nonostante la passione che prova per Albert Pharaon, la loro storia non può esistere. L’amante palestinese, se scoperto, manderebbe in frantumi il suo impegno e il suo ideale è più importante di qualsiasi altra cosa. E leggere queste pagine, in cui la convinzione di essere nel giusto, la pervicacia nel conseguire l’obiettivo, la freddezza di non vedere altra verità e sofferenze se non la propria, sono centrali, fa rabbrividire. Perché è questa visione che porta oggi a uccidere civili inermi, bambini, famiglie, visti solo come nemici da sterminare senza remore né sensi di colpa.
L’amante palestinese di Sélim Nassib [Un amant en Palestine 2004] – Edizioni E/O (2005)- traduzione di Gaia Panfili – pag. 179